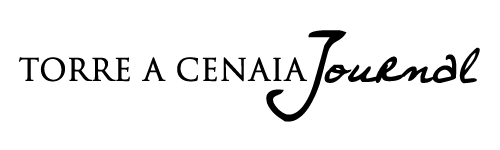Non molto tempo fa mi è capitato di cenare in un grazioso ristorante della costa toscana. Passeggiavo per le viuzze medievali di un borgo di mare, avevo un certo languorino, l’insegna era attraente, il menù esposto all’ingresso pure. Capirete, la carne è debole… sono entrato.
Appena scelti i piatti di pesce, il cameriere mi ha proposto nel calice un abbinamento un po’ più “ardito”, a suo dire. Un modo come un altro per suggerirmi una bollicina al posto del solito bianco fermo.
Va bene, mi suggerisca questa bollicina.
“Guardi, è di una piccola azienda locale, piccola ma con prodotti davvero notevoli. Vedrà che non potrà darmi torto… Le porto un Prosecco toscano come non ne ha mai assaggiati!”
Capirete bene. Alle parole “Prosecco toscano” ho cominciato a sudare freddo.
Le vene gonfie alle tempie, i pugni stretti alla tovaglia.
Per fortuna, un attimo dopo ho provato una sorta di tenera compassione per quel professionista. Da ex linguista, mi sono subito detto che non è colpa sua se le parole prendono strade che non dovrebbero. Che, come diceva Tullio De Mauro, il Signor Uso detta legge e occorre chinare la testa.
E, dopotutto, questo “Prosecco toscano” era un brut davvero niente male.
Che cos’è il Prosecco?
Anche se per molti sarà banale e superfluo, per moltissimi anzi troppi, davvero troppi, è necessario ricordare che cosa significa la parola “Prosecco”.
Quando parliamo di Prosecco non ci riferiamo genericamente a una tipologia di vino spumante, ma a una indicazione geografica tipica, ovvero a un territorio: il Veneto, con l’esclusione delle province di Rovigo e Verona, e il Friuli Venezia Giulia. Area che ha poi al suo interno due denominazioni di origine controllata e garantita: quella di Montello e Colli Asolani e quella di Conegliano-Valdobbiadene.
Questo significa, banalmente, che non può esistere Prosecco ottenuto da uve coltivate al di fuori di quelle regioni. Men che meno un “Prosecco toscano”.
Perché allora questo termine è andato erroneamente ad assurgere alla funzione di sinonimo per “vino spumante di facile beva”?
Senza dubbio, per l’incredibile successo che negli ultimi anni ha portato il Prosecco a consumi da capogiro, al punto da essere uno dei principali prodotti italiani conosciuti, e consumati, all’estero.
Si tratta del fenomeno linguistico dell’antonomasia: il nome proprio va a sostituire il nome comune. Forma di “volgarizzazione” non sempre apprezzata dalle aziende, poiché foriera di conseguenze a volte imprevedibili e sempre incontrollabili. Solo per citare altri esempi celebri: Biro e Bich per “penna a sfera”, Barbie per “donna o ragazza con determinate caratteristiche psico-fisiche”, Lysoform per “detergente” e così via. Nel vino era già accaduto, che una denominazione geografica prendesse questa china: il Chianti.
Un tale successo, come ben sa chi conosce il settore, si porta con sé inevitabilmente delle “zone d’ombra” e dei rischi (si vedano, appunto, gli innumerevoli scandali che hanno imperversato nel nome del Chianti) dettati da un mercato sempre più vorace ed esigente. Crescono gli ettari vitati di Prosecco, i milioni di bottiglie conquistano il globo terragno, le grandi aziende fagocitano le piccole, la guerra dei prezzi imperversa e le raffiche dei tappi scandiscono la vorticosa vita notturna di ogni locale alla moda.

E’ tutto oro, quello che frizza nel calice?
A stare ai numeri, pare di sì. Soprattutto per i prossimi anni.
Secondo le previsioni di Iwsr, l’istituto di ricerca al quale ogni due anni Vinexpo commissiona l’indagine sullo sviluppo del mercato mondiale del vino, il trend delle vendite delle bollicine crescerà dell’8,6% entro il 2020 per un totale di 2,9 miliardi di bottiglie, delle quali oltre 412 milioni saranno di solo Prosecco. La notizia non sta tanto nei numeri, quanto nel fatto che, sempre secondo Iwsr, il Prosecco supererà le vendite di champagne di fascia medio-bassa, confermandosi come la bollicina che dominerà l’evoluzione degli sparkling wines sul mercato dei prossimi anni.
Dagli attuali ritmi di crescita, le proiezioni ci dicono che le vendite di Prosecco raggiungeranno il più 14% nei prossimi cinque anni, portandolo a detenere il 9,2% delle quote di mercato dei vini frizzanti in tutto il mondo. La prima illustre vittima italiana di questa inarrestabile crescita sembra essere l’Asti, che si prevede in discesa del 6% nell’immediato avvenire; le altre bollicine tentano di difendersi come possono, ma se perfino le previsioni per lo champagne ipotizzano un misero più 1% nei prossimi cinque anni, che ne sarà del sottobosco delle bollicine senza nome?
Il punto è proprio questo, il nome
Cioè il brand. Conseguenza e causa allo stesso tempo del fenomeno dell’antonomasia che abbiamo appena visto, il Prosecco è diventato un vero e proprio brand al punto che i consumatori lo ricercano e lo ordinano declinando il nome anche in modo improprio. Non solo.
Tale “brand” si è conquistato da subito un solido posizionamento in una fascia di bisogni fino a oggi insoddisfatta nel campo delle bollicine, quella del “lusso di tutti i giorni”: lo dimostra il fatto che, a risentire maggiormente di questa inarrestabile avanzata, sia stato proprio lo champagne di prezzo basso. Una grande fascia di consumatori si è resa conto di poter accedere al piccolo lusso della bollicina: una bollicina non straordinaria ma comunque amabile, cool e, soprattutto, alla portata delle loro tasche. In questo sta la prepotente forza del Prosecco, difficile da scalfire: il posizionamento acquisito nella mente dei consumatori quale everyday luxury.

Ecco che la questione, per i competitor italiani e non solo, si tramuta in un’estenuante guerra di posizione lontana dall’essere risolta.
Senza dubbio, la prima cosa da fare è porsi una domanda.
Esiste un’alternativa al Prosecco?
La risposta è sì, e sta nella galassia di bollicine di qualità che stanno progressivamente fiorendo nel Bel Paese, che non hanno niente da invidiare alla celeberrima denominazione di origine ma che, purtroppo, soffrono ancora un grande, grandissimo deficit che tarpa loro le ali: quello di non essere riconosciute all’interno delle relative denominazioni di origine. Conditio sine qua non allo sviluppo successivo: quello di innalzare la denominazione a brand – al quale sarà poi necessario attribuire un solido e credibile posizionamento nella mente dei consumatori. Come dire che c’è tanta, troppa strada da fare per colmare il gap, tanta al punto che verrebbe voglia di gridare alla concorrenza sleale.
La Toscana in primis sta dimostrando di aver appreso la migliore arte della spumantizzazione e sempre più produttori si cimentano in metodo classico e Charmat con ottimi risultati. Unica pecca, appunto, tranne rarissime eccezioni, è l’essere costretti a declassare le proprie uve per poter provvedere alla spumantizzazione; il che significa lavorare uve locali di primissima qualità senza poterlo dichiarare. Una grave perdita di valore nella comunicazione e nella commercializzazione del prodotto, un pesantissimo freno che impedisce al territorio di crescere come brand.
Una guerra combattuta ad armi impari, dunque. Ma non per questo i toscani, e gli italiani tutti, si arrendono di fronte alle bollicine più inflazionate di sempre – e che, diciamo la verità, ci hanno pure un po’ stancato.
E allora, ecco un’alternativa direttamente dai vigneti di Torre a Cenaia, Antica Tenuta Pitti nota per il terroir particolarmente vocato alla coltivazione dei vitigni a bacca bianca.
Il Pitti Brut è un’elegante bollicina Chardonnay in purezza, ottenuta con il metodo di spumantizzazione italiano per eccellenza, il Martinotti, che ne esalta le note floreali e fruttate, donandogli un colore tenue e un perlage fine e persistente.
È prodotto con le stesse uve impiegate per ottenere il Pitti Chardonnay, uno dei prodotti flagship della Tenuta, la cui annata 2016 ha ottenuto il riconoscimento Fisar come miglior vino bianco della provincia di Pisa. Dunque, una bollicina “del territorio” amabile e versatile, degna dei migliori aperitivi (ad esempio, quelli che possiamo goderci in Piazzetta Pitti!) e non solo.

Che cos’è il metodo Martinotti-Charmat?
Il nome è dovuto a Federico Martinotti, direttore dell’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti, che intuì i vantaggi del far rifermentare il vino in grandi recipienti pressurizzati detti autoclave. I francesi si accorsero subito della preziosa intuizione italiana, al punto che Eugene Charmat ne acquisì il brevetto già nel 1910, motivo per cui il metodo fu ribattezzato in Martinotti-Charmat.
Essendo un metodo particolarmente adatto a esaltare le note fruttate dei mosti, ha trovato larga diffusione per la produzione di bollicine con vitigni aromatici: la sosta sui lieviti è infatti più breve rispetto a quella del metodo classico, il quale di fatto smorza le caratteristiche organolettiche dei vitigni andando invece a valorizzare il lavoro dei lieviti, con le caratteristiche note di panificazione.
A torto si ritiene migliore il metodo classico, poiché con il Martinotti è possibile eseguire la fermentazione in tempi minori agendo su grandi masse di vino, dimenticandoci che l’autoclave non è altro che una “grande bottiglia” ovvero un contenitore pressurizzato in cui avvengono gli stessi processi del metodo classico. La qualità di ciò che si ottiene dallo Charmat dipende inoltre dal tempo di permanenza sui lieviti: il Pitti Brut, ad esempio, vi permane dai tre ai cinque mesi, grazie ai quali riesce ad acquisire una finezza e un’eleganza che niente hanno da invidiare a più blasonate bollicine da metodo classico. Tendiamo inoltre a dimenticarci che esistono non poche etichette di pregio ottenute con il Martinotti-Charmat e che, a oggi, resta il metodo di spumantizzazione più utilizzato nel mondo.
Solo per restare in Italia, senza di questo non avremmo il Lambrusco, l’Asti e… il Prosecco!