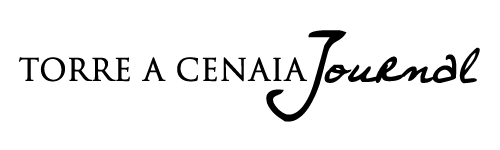Sabato 18 novembre, insieme Italia Nostra Sezione di Pisa, abbiamo fatto visita a quella che possiamo considerare a tutti gli effetti un’“istituzione” del nostro territorio. Ad appena una manciata di chilometri da Torre a Cenaia, nel cuore del piccolo e suggestivo centro storico di Crespina, si nasconde un vero tesoro: una collezione privata di arte contemporanea che non ha eguali al mondo, per il numero di opere ma soprattutto per il modo in cui sono state raccolte ed “esposte”. Non si tratta di una semplice rassegna di opere, ma della vita e del messaggio di un grande amante dell’arte: Carlo Pepi.
Visitare per la prima volta la sua collezione è un’esperienza disarmante. Appena varcata la soglia dell’antico palazzo, si viene catapultati nell’intimità dell’arte; la si coglie subito nuda, come spiata dal buco della serratura, senza la pesante tonaca della sacralità che impone un museo, una mostra o una comune collezione privata.
All’inizio si ha l’impressione di non dover essere lì – nessuno ci ha mai addestrato ad avere a che fare con l’arte collezionata ancor viva – poi, a poco a poco, si muovono i primi passi tra le tele accatastate alle pareti, si scansa un Nomellini o un Fattori, si urta un Lega con un lembo del cappotto, e improvvisamente è tutto familiare; abbiamo quasi pestato un Viani e ci è parsa la cosa più normale del mondo.
Ma, onde schiacciare altre avanguardie, facciamo un passo indietro.

Chi è Carlo Pepi?
“Una voce nel deserto”, come si definisce questa mattina nel sole che lo illumina alle spalle, in fondo alla grande sala del suo palazzo-museo (ma non chiamatelo museo!) a Crespina, di fronte alla folla che Italia Nostra ha radunato per lui da tutta la Toscana.

Una vita comune da libero professionista, uscito dottore dalla Facoltà di Economia di Pisa; una dedizione assoluta all’arte con una passione e un intuito che hanno del sovrannaturale, fin da quando era bambino.
Ha dominato più volte la cronaca, sfidandola come un surfista affronta la più nefasta delle grandi onde: la scoperta delle false teste di Modigliani nei fossi di Livorno, nel 1984; alcune esposizioni che non poté fare a meno di “smascherare” seppure firmate da celebri e potenti curatori; l’episodio del crocifisso attribuito a Michelangelo e acquistato dallo Stato a una cifra esorbitante, puntualmente rivelatosi una patacca; numerose mostre da lui curate al fine di rendere celebri i suoi amati Macchiaioli e non solo; l’investitura da parte del celebre storico James Beck a Direttore della sezione Falsi e Contraffazioni dell’Associazione internazionale “ArtWatch International Inc” di New York, e altro ancora.

Un collezionista d’altri tempi
Oggi vive a Crespina e, rampollo di una illustre stirpe, possiede due dimore storiche stracolme di opere d’arte. Più di 20.000 pezzi dice soddisfatto, ma poco convinto – nemmeno lui sembra sapere esattamente che cosa contengano le sue stanze.
Ci accoglie nella sua prima dimora, nel centro della piccola cittadina sulle colline pisane. Il sole investe la lunga facciata gialla e il parco pullula di visitatori: si percepisce l’eccitazione generale, il tesoro lì conservato è così celebre da avere assunto i connotati delle cose leggendarie.
Nella grande sala al piano terra Carlo si presenta, e ci racconta una vita emozionante, immolata all’arte senza alcun fine monetario. Anzi, quella che si intuisce essere una grande fortuna economica di lungo corso, è stata messa a dura prova da Pepi: non è da tutti andare scoperto con 7 banche contemporaneamente e dover “sfamare” i propri artisti con miseri assegni di poche centinaia di migliaia lire, accontentandosi di acquistare opere minori e non potendo far niente per evitare che le più importanti, di una folla di pittori bistrattati dai “grandi” critici, finiscano al macero. È un cruccio di cui non si è mai liberato, quello di non aver preso tutto, di non aver potuto acquistare ciò che meritava di essere salvato.
I “suoi” artisti sono i contemporanei della propria terra: Crespina e il pisano, ma soprattutto Livorno. Ha iniziato lottando per riscattare i Macchiaioli, quando nessuno ne capiva il messaggio rivoluzionario, poi si è avvicinato ai viventi e li ha seguiti, acquistando tutto quello che poteva e riuscendo così a testimoniare tutti quegli straordinari percorsi artistici, dagli albori al camposanto.

Renato Lacquaniti è uno dei suoi prediletti, figlio di quella tradizione livornese nata sulla scia di Fattori che ha rischiato di finire nel dimenticatoio della storia. Narra episodi intensi e commoventi, scene che intrecciano profondamente la sua vita con quella dell’artista. Ne elogia la visione avanguardista, i temi di attualità trattati prima di chiunque altro, la critica che cominciava a comprenderlo quando lui era già un passo oltre.
Di Mario Nigro racconta gli ultimi istanti, le lacrime agli occhi su letto di ospedale, quando fece appena in tempo a mostrargli le sue opere sull’ultimissima storia dell’arte fresca di stampa. Poche ore dopo spirò, felice – così parve a Carlo – per aver conquistato, seppure per un pelo, un minimo giusto riconoscimento.
Questa è la sua vita, una continua lotta per il bello, per il “bello giusto” verrebbe da dire. Contro ogni tipo di potere, di cui sappiamo essere affollata la strada della grande arte. Una vita scomoda per molti, che molti hanno tentato di mettere a tacere, inutilmente.
All’improvviso alza una tela raffigurante un Don Chisciotte e afferma di non aver più voglia di lottare contro i mulini a vento, ma tutti capiamo esattamente il contrario: continuerà ad alimentare la sua Wunderkammer finché il cielo glielo consentirà, insolito collezionista di meraviglie d’altri tempi.

Un appassionato narratore
A chi gli chiede perché diamine non affigga alle pareti tutto quel bendiddio, lui risponde che avrebbe bisogno di venti o trenta palazzi per dare luce a tutte le sue opere, e allora tanto vale tenerle ammassate così.
Non esiste un catalogo completo della sua collezione, ma Carlo sembra avere tutto registrato in mente alla perfezione: dal più piccolo schizzo nascosto sotto a un cuscino, alla rivista ammassata in quintali di quotidiani sotto a una scrivania, proprio tutto.

Questo suo “metodo” di archiviazione costringe a un tipo di visita insolita e potente: è un continuo farsi strada, un tracciare sentieri indipendenti in mezzo a cumuli di arte. Si passa in fila indiana, a volte sfiorando le pareti, altre circumnavigando isole di tele ammucchiate in mezzo a grandi stanze o scansando asciugamani e rotoli di carta igienica perché sì, anche i bagni ne sono pieni. Ogni visitatore è costretto a tracciarsi una rotta e a scrivere una storia, a tenere fra le dita un filo narrativo sempre diverso.
Di tanto in tanto ci imbattiamo in Carlo, che dispensa aneddoti e ricordi a gruppetti di ospiti. E’ un comunicatore di razza, l’entusiasmo cresce nei suoi occhi a ogni cambio di stanza: dove mai ci è capitata, un’esperienza simile?

Ha ragione: l’accademia e i musei fanno terra bruciata, spengono e ammutoliscono. E, quel che è peggio, pare proprio che un Carlo Pepi sia inconciliabile con gli ambienti “tradizionali” cui siamo abituati. Se soltanto riuscissimo a innestare questa sua forza in un comune luogo di arte e cultura avremmo fatto bingo. Peccato che, fuori da qui, sia sempre il solito deserto.
Ma nel deserto si è costretti a guardare avanti, questo Carlo Pepi lo sa bene, ed è forse per questo che la sua voce solitaria continua a lanciare messaggi da veggente.